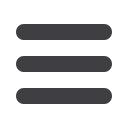

“N
on farti cadere le braccia”,
cantava Bennato ormai pa-
recchi anni fa.
Eppure davanti a certe notizie
sembra proprio impossibile non restare basiti. E amareggiati.
La posizione dell’Europa sul latte in polvere nei formaggi è
una di queste.
Si parla tanto di made in Italy, di qualità, di proprietà orga-
nolettiche, di cultura alimentare, di orgoglio manifatturiero e
poi bastano poche asettiche righe per mandare a monte tutto.
Naturalmente speriamo in una rapida resipiscenza. Però il
segnale non è certo dei migliori, perché rivela delle logiche
difficilmente comprensibili ma fortemente dominanti.
E pensare che uno degli stimoli (e delle eredità) di Expo (da
pag.4) dovrebbe essereproprioquesto: gestire, vivere, diffonde-
re il cibo come una responsabilità condivisa da tutta la filiera.
Senza pressapochismi o ipocrisie.
Senza faciloneria né compromessi. E senza abdicare alla forte
carica identitaria di cui ogni cultura alimentare si fa messag-
gera e testimone.
Ciò non vuol dire che si debba osteggiare ogni forma di cam-
biamento. Anzi, la recente ricerca di Doxa per Coop (pag 6),
ben sottolinea una progressiva apertura (anche a livello globale)
verso le novità e le contaminazioni. A patto però che non si
cancellino le eccellenze in nome di un appiattimento incolore.
Incappare nell’amorfo (sia esso un prodotto, un negozio, una
pubblicità) equivale a mettere gasolio in un motore a benzina:
grippa. Serve carattere: non si scappa. Per questo si assiste
sempre più spesso alla nascita di format variegati.
Una volta appurato che in termini dimensionali il superstore si
riconferma vincente (Iri da pag. 10), scatta la gara a qualificare
il punto di vendita in modo peculiare. Per uscire fuori dal
coro, essere riconoscibile, avere qualcosa di speciale da dire.
Per esempio puntando sull’integrazione della formula food e la
contaminazione tra canali. Un trend molto vitale, che ha come
obiettivo quello accompagnare il potenziale consumatore nel
maggior numero possibile di occasioni di consumo (da pag.14).
Oppure imboccando la formula del temporary (da pag 16),
fenomeno ancora marginale nell’ambito del largo consumo,
ma con grandi potenzialità di marketing, in quanto canale
privilegiato per mettere in contatto l’utente con il brand.
Ma a dare carattere al punto vendita, in un mercato ipercon-
nesso e sempre più attento al cambiamento, sono anche le
nuove tecnologie. Visibili e sperimentabili in una fucina in
divenire come può essere definito lo store del futuro realizzato
da Coop all’interno di Expo (da pag 48). Uno spazio d’acquisto
futuribile, ma in grado di mantenere viva il “retaggio buono”
della socialità, tipica del mercato rionale. Lo store, così, diventa
sempre più un laboratorio in cui la dinamica del bottom down
non può più viaggiare da sola e dove la logica univoca non è
più sostenibile. Al contrario, invece, gli input della clientela
possono (e devono) generare una risposta concreta e quanto
più possibile immediata da parte dell’offerta (pag.52).
L’offerta, dunque si va affinando progressivamente. E alcuni
mercati si rivelano più solleciti di altri. Vediamo, per esem-
pio, che le preparazioni rituali, effettuate cioè secondo ben
precisi dettami religiosi, hanno un appeal sconosciuto fino
a poco tempo fa. E aprono orizzonti di business veramente
promettenti. È il caso del kosher, su cui si è di recente discusso
nel corso di un evento in Bocconi, analizzandone l’interesse
(oramai neanche più troppo latente) che esso può avere per
la Grande distribuzione (pag 38).
Particolarmente vivace risulta anche il pet market (nella sua
duplice declinazione di food e care). Il risultato è oggi un’of-
ferta variegata e di qualità che ha impresso una marcia in più
al comparto (da pag. 20).
Fa piacere constatare questo dinamismo. Nonostante tutto.
La speranza è che questi slanci non vengano repressi e mor-
tificati da politiche livellatrici (vedi, come si diceva, l’
affaire
latte in polvere). L’Italia non lo meriterebbe.
Carmela Ignaccolo
EDITORIALE



















